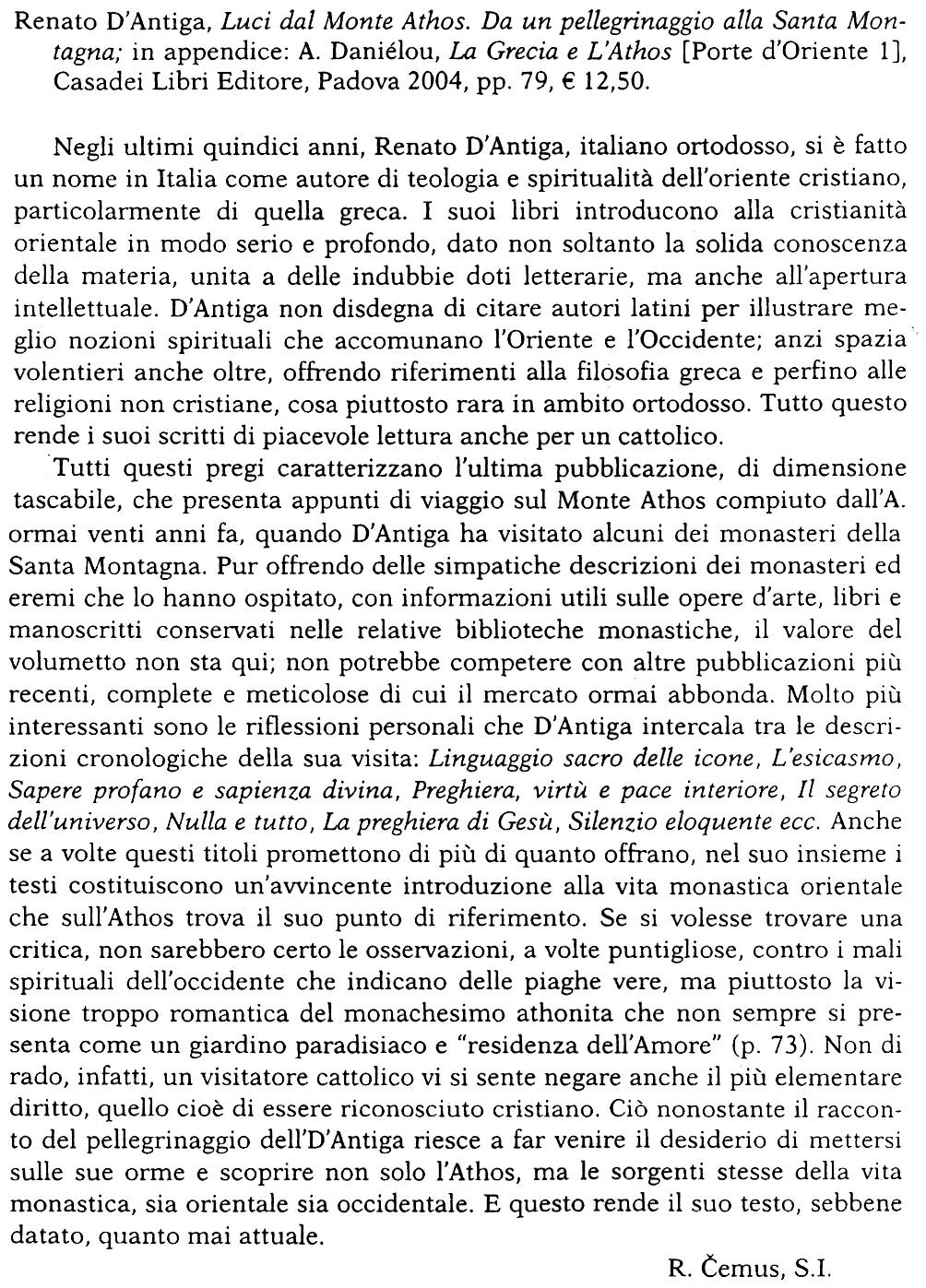Il Mattino del 2/11/2007
Quando Daniélou ritrovò la sua anima nell’India di Tagore
di Francesca Bellino
Alain Daniélou considerava l’India la sua vera patria. Nato in Francia, a Losanna, il musicologo, ricercatore, scrittore, pittore, viaggiatore, uno dei più eminenti orientalisti contemporanei, dopo il suo approdo sulle rive del Gange non diceva più di essere un francese, ma «un indiano convertito all’induismo». Daniélou scopre l’India all’inizio degli anni ‘30, se ne innamora e sceglie di viverci. Naturalmente anche il giro del mondo che intraprende nel 1936 insieme all’amico fotografo Raymond Burnier è ricco di tappe indiane. I due, che decidono di percorrere il Paese in roulotte, il loro sguardo è curioso e affamato di conoscenza. Non si annoiano mai e quell’esperenza è raccontata nel libro Il giro del mondo nel 1936.
Daniélou per più di vent’anni vive a contatto con gli indiani, «pronto a fare tabula rasa della sua cultura». La prima persona che incontra è il poeta Rabindranath Tagore, la sua città diventa Benares dove vive dividendo il suo tempo tra l’attività di ricercatore all’Università, lo studio del Sancrito e dell’hindi – per lui lingue fondamentali per capire la cultura indiana – lo yoga e la scoperta delle canzoni tradizionali. Subito si converte all’induismo, un apparente paradosso per il figlio di una madre cattolica, un padre anticlericale e un fratello futuro cardinale. Il suo maestro gli da il nome di Shiva Sharami (il protetto di Shiva). Non si sente un guru, né un profeta, ma quando, nel 1958, torna in Europa, per lui «un Paese malato», il suo intento è far conoscere l’India tradizionale all’Occidente e far capire che l’induismo può portare un nuovo Rinascimento. Fino alla morte, 10 anni fa, solo l’Italia riuscirà a farlo sentire a casa.

Autocar di ottobre 2008
Indù vai?
Appassionato credente e studioso dell’induismo, l’orientalista e musicologo francese Alai Daniélou è stato anche un pioniere dei raid automobilistici. Come racconta in un libro di prossima pubblicazione
in occasione del centenario della sua nascita, vorrei dedicare questa pagina ad Alain Daniélou. Nato in Francia il 4 ottobre 1907 da madre fervente cattolica (aveva fondato anche un ordine religioso) e padre anticlericale bretone più volte ministro sotto governi socialisti, Alain trascorre l’infanzia in campagna con precettori, un’immane biblioteca e un pianoforte, scoprendo sin da allora la musica e la pittura.
Negli Stati Uniti per gli studi universitari vendeva i suoi quadri e suonava il piano durante la proiezione dei film muti. Ritornato in Francia studiò canto con Panzera, danza classica con Legat, il maestro del grande Nijinski, e infine composizione con Max d’Olonne. Diede dei recital e fece delle mostre.
Molto sportivo, Daniélou è stato campione di canoa e un abile pilota di auto da corsa. Nel 1932 compì un viaggio di esplorazione nel Pamir afgano e nel 1934 partecipò al raid automobilistico Parigi-Calcutta. Fu amico di Cocteau, Diaguilev, Stravinskij, Nabokov e dei principali intellettuali dell’epoca.
Dopo innumerevoli viaggi in Africa e in Oriente si stabilì in India, dove soggiornò dapprima presso il poeta Tagore che gli affidò l’incarico di curare i suoi rapporti con gli amici Paul Valéry, André Gide e Benedetto Croce, e lo nominò direttore della scuola di musica a Shantinketan.
Trasferitosi a Benares, scoprì la cultura tradizionale indiana e per vent’anni si dedicò allo studio della musica classica indiana presso i più grandi maestri. Collaborò anche alla fondazione di un partito politico, lo Janaz Sang, che propugnava la difesa della società indù contro le moderne idee occidentali in forte opposizione al Mahatma Gandhi. Dopo l’indipendenza dell’India fece ritorno in Europa e nel 1963 fondò a Berlino, e nel 1970 a Venezia, l’Istituto interculturale di Studi Musicali Comparati promuovendo la scoperta della musica d’arte asiatica nell’Occidente. Si è spento in Svizzera nel 1994 e, da buon indù, è stato cremato.
Nella sua autobiografia La via del Labirinto (ed Casadeilibri 2004) racconta con divertita ironia il disorientamento che provocava a conoscenti e visitatori della sua casa di Parigi quando interrompeva le sue riflessioni sull’induismo e sulla musica indiana, dicendo che aveva voglia di rilassarsi e scendeva in garage per guidare la sua sportiva preferita.
Di Alain Daniélou vogliamo suggerire Il Giro del Mondo nel 1936 in uscita in questi giorni per la Casadeilibri. Chiediamo a Jacques Cloarec, presidente della Fondazione Alain Daniélou, quale fosse il suo rapporto con le automobili: “All’inizio degli anni ’30 Alain Daniélou incontra lo svizzero Raymond Burnier, un giovane facoltoso col quale intraprende grandi spedizioni, il più delle volte in macchina. In particolare Daniélou ricorda, nell’autobiografia La Via del Labirinto , un avventuroso viaggio dall’Europa fino all’India. Sono entrambi giovani appassionati e per tutta la loro vita guideranno a forte velocità automobili molto potenti.
La prima è la Hispano-Suiza della quale Daniélou disegna la carrozzeria e che finirà abbandonata sui monti Carpazi, dove si era rifiutata di continuare il viaggio. Seguiranno delle Citroën a trazione anteriore, le auto dei gangster dell’epoca, poi una Matford, che vendettero all’attore Jean Marais quando andarono a vivere in India.
Qui fecero arrivare, per la prima volta, una roulotte da Los Angeles; sarà una spider Forda a trainarla durante le spedizioni nella giungla per fotografare i templi abbandonati.
Quando li incontrai nel 1962 Raymond Burnier era già definitivamente conquistato dalla Jaguar: ne acquisterà vari modelli fino alla sua prematura morte nel 1968. Daniélou ha, in questo periodo, una rara Austin-Healey cabrio 4 posti. Poi arriverà una grossa Jaguar e un’immensa Mercedes cabriolet, delle quali non fu mai troppo convinto.
Ma negli anni ’70 scoprimmo entrambi le Porche, diventandone degli appassionati che non avevano occhi per nessun’altra. Comprai inizialmente una 912 poi abbiamo posseduto le prime 911 Targa, alle quali siamo rimasti fedeli. Erano le macchine ideali per inerpicarsi sul S. Bernardo quando viaggiavamo da Roma a Parigi e sul Brennero quando andavamo da Venezia a Berlino. Epoca benedetta! Poche limitazioni alla velocità e traffico assai meno intenso. Daniélou aveva una guida assai nervosa e veloce.
Mi ricordo viaggi da Roma a Venezia in 4 ore, con punte di 230 km/h. La maggior parte delle persone che viaggiarono con lui ricordano quell’esperienza come una delle più paurose della loro vita.
Daniélou non ebbe mai incidenti gravi; ma durante gli anni ’80, quando i limiti di velocità si fecero più frequenti, smise di guidare, poiché si annoiava. La passione per le auto è un aspetto particolare della sua personalità, che sorprende i lettori dei suoi numerosi libri tradotti in italiano, poiché in apparente contrasto con la sua immagine di filosofo, saggio e sapiente”.