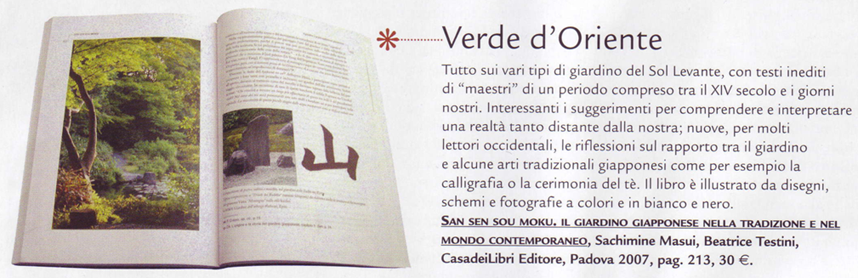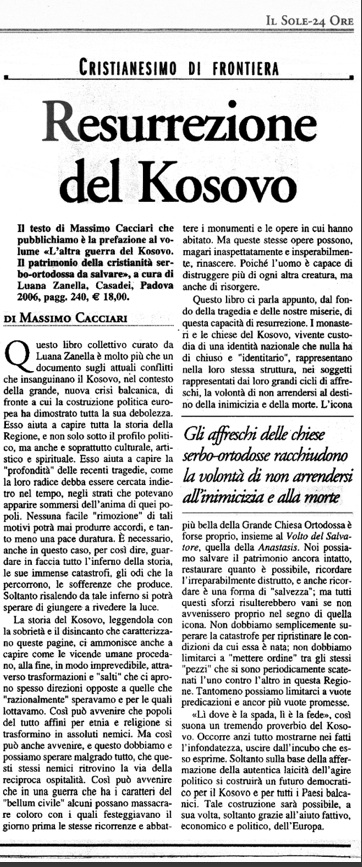Il Riformista – 7/03/2009
“L’iniziazione inesplorata di una geisha”
di Anna Mazzone
Spesso l’Occidente le vede come mere “intrattenitrici”. Ma dietro la formazione di una musa moderna c’è molto di più. Miriam Bendìa racconta gli sforzi, le paure e la passione di una Maiko per aggiungere l’arte. Avete mai sfiorato lo sguardo di una geisha? Le avete mai viste correre su per le scale del tempio, sorridenti mentre il vento dolce di Kyoto prova a scompigliargli l’acconciatura austera? Le avete mai osservate coprirsi le labbra intense e abbassare gli occhi dopo una battuta mentre sorseggiano del thè verde? Le geishe sono un mistero. Lo resteranno ancora. È questo il loro incantesimo perpetuo. Non si riesce mai a toccarle fino in fondo, a conoscere l’abisso profondo che si cela dietro il loro sorriso. Per questa ragione continuano a farci sognare e a stregarci. Quando una geisha ti passa davanti per strada con il suo passo delicato e veloce, il tempo si ferma e si resta impietriti a fissare l’incanto in movimento. Anche se è già scomparsa dalla nostra visuale, se ha voltato l’angolo ed è in un altro dove. Le geishe lasciano una scia che non si può etichettare, ma è certo che stordisce, anche se solo per un breve istante. È difficile parlare di geishe. Sono sfuggenti, come sabbia che scivola in silenzio tra le dita. Eppure, il nuovo libro di Miriam Bendìa, Diario di una Maiko della CasedeiLibri riesce ad avvicinarsi molto a quel tesoro inesplorato che è la quotidianità di una geisha.
Diario di una Maiko è un’incantevole e poetica galleria dedicata a quelle muse della femminilità e dell’arte rappresentate da tutte quelle donne giapponesi che decidono di diventare geishe. Culturalmente, noi occidentali siamo abituati a scelte diverse, che comportano il più delle volte l’oscuramento del proprio corpo, la negazione di qualsiasi appiglio erotico e sensuale e non già la sua piena esaltazione, il suo trionfo artistico. Le geishe sono esattamente il contrario. In giapponese il loro nome è composto da due kanji: gei, che significa arte e sha, che significa persona. Le geishe, dunque, incarnano l’arte con la loro vita e all’arte sono fedeli e sempre devote. Sono danzatrici, musiciste, attrici. Le geishe compongono haiku, le brevi poesie nipponiche, e sanno affrontare discussioni letterarie e filosofiche, ma anche economiche e politiche. Tutto, nella loro bocca e tra le loro dita diventa arte.
Il romanzo della Bendìa è una galleria fotografica sulle geishe.
Delicato, poetico, dinamico. I magnifici ritratti firmati da Michael Chandler scandiscono il ritmo diaristico del libro che non ha una natura documentaristica, ma piuttosto squaderna sapientemente (e dolcemente) le aspirazioni della giovane Sotori, che a quindici anni decide di seguire la sua strada per diventare una geisha. E come tutte le adolescenti del mondo Sotori ha un diario, che segna i piccoli momenti importanti della sua vita. Con orgoglio e fierezza descrive la gioia di essere stata accettata come Maiko in una okiya di Kyoto, ossia una delle tante geishehouse dove un piccolo esercito di donne inizia le giovani Maiko all’arte del levigare i propri corpi, per farne opere di assoluta bellezza che possano facilmente accendere il desiderio degli uomini. La nuova Maiko impara a vestirsi, a truccarsi, a pettinarsi secondo una logica ferrea. La vita nell’okiya non è affatto semplice.
Bisogna studiare tanto e imparare in fretta. Quando si entra in una okiya si taglia il cordone ombelicale con l’esterno, con gli affetti, con la famiglia, e si entra a fare parte di una sorta di mondo parallelo, fatto di obbedienza e di duro lavoro. Diventare opera d’arte è un’attività complessa, che richiede sforzo e passione. Sfogliando Diario di una Maiko ci si rende conto di quanto cuore ci sia dietro il diventare quello che noi occidentali – assai volgarmente – definiamo spesso come delle mere “intrattenitrici”.
Intervista di Viviana Gasperini a Miriam Bendìa
Che cosa significa per Sotori feel good ?
Danzare. Mentre balla, galleggiando tra le note dello shamisen, she feels good.
Che cosa vuol dire geisha nel 2009?
La parola geisha è composta da due caratteri giapponesi: gei significa “arte” e sha“persona”. Se maiko (apprendista geisha; ragazza danzante) vuol dire danzatrice, geisha dunque significa artista. Il loro mondo simboleggia e riassume tutti i problemi della modernizzazione che colpirono la società giapponese, soprattutto all’inizio del secolo. In quel periodo, anche loro erano nell’occhio del ciclone!
Allora c’erano diverse posizioni, riguardo al karyukai (il mondo del fiore e del salice): una, spietata e progressista, affermava che le geiko (il dialetto di Kyoto per geisha) erano ormai completamente anacronistiche e che la professione doveva essere lasciata morire di morte naturale.Un’altra più moderata affermava che dovevano cercare di aggiornarsi per adattarsi ai tempi moderni e poter sopravvivere in essi.Solo pochi nostalgici ripetevano, senza sosta, che il Giappone avrebbe perso un tesoro prezioso della sua tradizione se le geisha fossero scomparse o mutate.
Le okasan (geisha mother) più anziane raccontano spesso quali difficoltà abbia dovuto affrontare il karyukai, in quel difficile periodo! Ma proprio in virtù della sua importanza, per l’identità culturale nipponica, il fiore del karyukai non è avvizzito nell’indifferenza generale. E oggi le maiko e le geiko sono tornate ad essere un simbolo ineliminabile del Giappone e soprattutto della città di Kyoto, roccaforte della loro tradizione: non a caso solo qui potete ancora incontrare le autentiche giovani maiko, le allieve nell’arte della geisha.
Si diventa geisha per una tradizione di famiglia o è una scelta personale?
Un tempo addirittura era necessario iniziare il proprio percorso di studi appena si compiva l’età di sei anni, sei mesi e sei giorni e accadeva proprio come si racconta: le bambine (generalmente appartenenti a famiglie molto povere di contadini o pescatori) venivano vendute alle proprietarie delle okiya (geisha houses). A quel punto perdevano ogni contatto con i genitori per entrare in una nuova famiglia , quella della geisha house che le accoglieva. Immaginate il trauma! Difficilmente riuscivano poi a liberarsi da quel legame, poiché dal primo giorno il debito che contraevano con la loro okasan era altissimo. Alla cifra versata per comprarle si aggiungevano tutte le spese per il mantenimento, l’educazione e la salute. Quando infine erano delle vere e proprie geisha, e iniziavano a lavorare, dovevano ripagare con i propri guadagni la okasan e il loro debito aumentava ancora con le nuove spese (basti pensare ai costosi kimono e ai cosmetici necessari per la professione). Poche artiste riuscivano dunque a liberarsi e a divenire autonome…
Oggi però è tutto molto diverso. Innanzitutto nessuna bambina viene venduta a una okiya, per fortuna! Le ragazze che vogliono diventare geisha lo decidono per loro conto, spesso anche con grande disappunto dei genitori. Come è accaduto a Sotori!
Quella della geiko è diventata una vera e propria vocazione, vissuta con grande entusiasmo e consapevolezza. Per essere accettate in una okiya si deve essere presentate alla okasan da qualcuno che goda della fiducia e del rispetto della geisha house. E si può iniziare il percorso di studio solo dopo aver completato la scuola dell’obbligo (tra i quindici e i sedici anni). Anche Sotori, nel romanzo, ha rispettato questa regola ed è stata accolta nella sua okiya solo nel 2005, quando aveva finito gli studi e aveva appunto compiuto quindici anni. La okasan si reca personalmente nella casa dell’aspirante maiko e parla a lungo con lei e con i genitori, spiegando in cosa consisterà la futura vita della figlia. Se la ragazza viene infine accettata dalla okami (geisha mother), lascia la dimora paterna e si trasferisce stabilmente nella okiya.
All’inizio sarà solo una shikomi, poco più che una cameriera. Per circa sei mesi dovrà assolvere le faccende domestiche, aiutando il personale di servizio, e comincerà a seguire i corsi presso il Kaburenjo (il luogo per la pratica della danza e della musica) del suo distretto: in pratica la scuola . In questo primo stage della formazione deve anche apprendere l’antico dialetto di Kyoto molto differente dal linguaggio abituale giapponese…
Dopo circa sei mesi come shikomi, superando un esame riguardante le lezioni di danza, di musica, di canto, di cerimonia del tè e portamento, si accede al secondo stage del corso: si diventa una minarai.
A questo punto una geisha o una maiko più esperta assumeranno il ruolo di onesan (sorella maggiore), per continuare ad insegnare tutto ciò che non si apprende in una classe…
Come minarai l’allieva deve osservare e imparare , quindi inizierà a pettinarsi i capelli nello stile Wareshinobu e a indossare i kimono tradizionali. Accompagnerà la propria onesan ai vari banchetti, per osservarla mentre intrattiene i clienti ed imparare le tecniche di una vera geisha.
Dopo un breve periodo come minarai, solitamente un mese, si celebrerà il suo misedashi: il suo debutto ufficiale come maiko!
Per tre giorni la nuova maiko sarà la star del suo distretto, indosserà il kimono nero delle occasioni formali e riceverà e farà visite nell’intero quartiere per avere gli auguri di tutti!
Dopo il debutto continuerà, per tre anni, a poter acconciare i capelli solo con lo stile Wareshinobu, quindi dopo ulteriori esami potrà passare allo stage successivo e adottare lo stile Ofuku delle maiko più esperte. A quel punto si dirà che ha avuto il Mizuage.
Per altri tre anni proseguirà nei suoi studi: la mattina seguirà le lezioni nelle varie arti, poi si preparerà per i parties serali, nei quali intratterrà i clienti mettendo in pratica ciò che impara a scuola, insieme alle sue compagne.
Inoltre prenderà parte ai vari festivals e alle numerose celebrazioni per le festività ufficiali. Al termine dei cinque anni di studio come maiko, se deciderà di non sposarsi, si potrà svolgere in suo onore la cerimonia dell’erikae (il cambio di collare , che da rosso diviene bianco nel kimono) per acclamarla come geisha.
Anche come geisha continuerà sempre a perfezionarsi nelle arti e a lavorare…
Per capire meglio il mondo di Sotori, potresti descriverci una giornata tipo?
La sua giornata è molto intensa… La mattina è impegnata con le varie lezioni nella scuola del Kanburenjo. Il pomeriggio, più o meno verso le quattro, iniziano a prepararsi tutte, all’interno dell’okiya, per gli o-zashiki ( appuntamenti) serali nelle o-chaya (teahouses). L’orario di inizio per il lavoro delle geisha sono le sei del pomeriggio e restano impegnate nelle danze, nei canti e nelle conversazioni delle o-chaya per tutta la sera fino a tarda notte. La maggior parte dei banchetti termina verso la mezzanotte, ma alcuni possono protrarsi oltre e difficilmente rientrano nell’okiya prima delle due di notte.
Poi ci sono le festività nazionali che richiedono la loro presenza, a volte nei templi e nei santuari a volte altrove nella città. Ci sono i pranzi di lavoro con i clienti e anche gli impegni fuori città nei meeting o in altre province, nel qual caso devono restare fuori per due o tre giorni o una settimana…
Cosa fa Sotori al di fuori del suo studio? Ci sono delle situazioni in cui “non è una maiko” (esce con gli amici, non in kimono…)?
Il tempo libero, per lei, è davvero molto molto poco. In linea di massima la domenica è il giorno che può dedicare a se stessa (ma non ha tutte le domeniche libere), ai suoi interessi e alle amicizie. La domenica infatti le lezioni non ci sono e le o-chaya sono, generalmente, chiuse. Nei giorni free, se lo desidera, può uscire indossando abiti occidentali, a volte anche con i capelli sciolti e non acconciati nello stile Wareshinobu. Con il tipo di educazione che ricevono, basata sull’arte e sulla disciplina, le maiko crescono più in fretta e risultano, agli occhi esterni, molto più mature rispetto alle loro coetanee… Del resto chi non riesce a evolversi velocemente non resiste in questo mondo e abbandona presto la scuola…
Ma possiamo immaginare quanto sia complicato e faticoso conciliare i desideri di ragazza con i doveri di maiko. Conciliare il ruolo di allieva con l’età adolescenziale è una delle imprese più complicate da affrontare, giorno dopo giorno…
A volte le apprendiste invidiano un po’ le ex-compagne di scuola che percorrono strade differenti e godono, certo, di una maggiore libertà. Una maiko, da quando inizia la formazione da geisha, deve lasciare la casa dei genitori. Possono tornare a passare qualche giorno da loro solo due volte l’anno: in occasione delle festività per il nuovo anno e, a metà agosto, per l’importante Festa della Famiglia.
Possono comunque incontrarsi con amici e parenti quando vogliono e trascorrere del tempo insieme (se non hanno impegni con l’okiya), ma ormai vivono nella geisha house. Qui hanno una nuova famiglia: la okasan, la onesan, che di solito è già una vera geisha e che presto andrà a vivere per conto suo, avendo terminato i primi cinque anni di formazione, e altre maiko. Finché sono delle geisha non possono sposarsi, se decidono di farlo devono rinunciare alla carriera di artiste. Possono avere un fidanzato ma non sposarsi. In caso contrario, se desiderano prendere marito e vogliono comunque restare nel mondo del fiore e del salice, possono aprire un’okiya oppure diventare insegnanti nel Kanburenjo del distretto.
Secondo te, cosa pensa la società giapponese di Sotori e delle sue scelte?
Un giornalista, Tanako Iwao, ha scritto: “Perché il nostro corpo ha l’ombelico? Perché abbiamo le ciglia? Sembrano cose senza una funzione utile, ma potremmo farne a meno? Le ciglia proteggono gli occhi dalla polvere, dall’ombelico passava il nutrimento nel grembo di nostra madre. Secondo i medici, l’ombelico è il centro del nostro addome, il centro della nostra forza. Se non avessimo l’ombelico come concentreremmo la nostra energia? Secondo me, le geisha sono l’ombelico della società. Chi afferma che la loro utilità è scomparsa, dovrebbe provare a rinunciare al proprio ombelico”.
Le maiko sono l’anima viva del Giappone moderno: uno dei simboli più amati e rispettati dal popolo nipponico. In pratica le maiko, in quanto artiste, sono per i giapponesi delle star, quello che i vip di Hollywood rappresentano per gli occidentali… E anche di più! Un mito, un sogno, un ideale, un tesoro da custodire.
Negli studi che Sotori sta facendo, qual è la cosa che trova più difficile?
All’inizio, è stato molto faticoso per lei abituarsi a portare i capelli sempre acconciati nella complicata pettinatura tradizionale. A volte, invidia la libertà delle ragazze che possono lasciare i propri capelli liberi di consumarsi al vento. Le maiko devono sottoporsi a lunghe sedute nei saloni di bellezza, dove un acconciatore crea la scultura meravigliosa che decora la loro testa. Mani sapienti le pettinano, una volta ogni cinque giorni, e un po’ le torturano. Al termine del processo sta a loro mantenere intatta l’opera d’arte, fino alla seduta successiva! Per questo non dormono su un normale guanciale ma riposano sul tipo tradizionale: il takamakura (alto cuscino).
Si tratta di uno speciale guanciale posto su una base rigida, serve per sostenere il collo senza toccare i capelli. Un normale cuscino altrimenti rovinerebbe la complicata acconciatura tradizionale. Questa è una delle cose più difficili da apprendere! Per allenarle a dormire nella giusta posizione la okasan sparge del riso sulle stuoie, sotto la loro testa, tutto intorno al takamakura. Se, mentre dormono, la testa scivola dal supporto il riso si attacca ai capelli. In quel caso, il giorno seguente, devono subire da capo la fastidiosa tortura per esibire di nuovo un’acconciatura perfetta.
E invece, secondo te, qual è l’aspetto più bello del lavoro di una geisha?
Poter indossare raffinati kimono, ogni giorno, è un raro privilegio. Imparare a indossare un kimono, nel modo giusto, è un altro degli aspetti più complicati dell’addestramento da maiko. Nessuno impartisce loro lezioni sull’argomento. La maggior parte delle apprendiste impara come muoversi in modo aggraziato grazie alle lezioni di danza classica giapponese. I gesti impacciati comunque vengono subito notati dalle okasan che non si astengono, mai, dal rivolgere un severo rimprovero a una maiko imperfetta. Un indumento esigente come il kimono richiede lo sviluppo di una nuova personalità e occorre diverso tempo prima di acquisire la disinvoltura che si esige da una geiko. Le prime volte nelle quali lo indossano, le allieve si affacciano dall’okiya piene di incertezze, spesso dimenticando anche il motivo pratico dell’uscita, e si concentrano solo sulla camminata. Alla fine i movimenti giusti diventano naturali ma, mentre li assorbono, si rendono conto che cominciano a sviluppare una seconda anima. Non è un caso che i gesti relativamente limitati, nel linguaggio corporeo giapponese, siano calibrati sul kimono. Le maiko sono talmente condizionate dal loro involucro di seta che anche quando scelgono abiti occidentali sembrano indossare tutte kimono invisibili e gesticolano come se lunghe maniche immaginarie ostacolassero realmente i movimenti delle braccia.
Il kimono è una delle cose che le distingue dalle altre donne giapponesi. Loro lo indossano in modo molto più aggraziato rispetto alle signore che una volta o due l’anno, in occasione della laurea del figlio o di un matrimonio tra amici, tirano fuori l’abito tradizionale per esibirlo ma poi sono, visibilmente, a disagio nella complicata veste. Ma, insieme alla naturalezza e alla grazia con le quali una geiko sfoggia il kimono, sono tanti altri gli indizi che la fanno riconoscere a un occhio sensibile al linguaggio della seta. Gli elementi del kimono infatti costituiscono un vero e proprio codice sociale.
La visione posteriore di una donna inginocchiata in kimono mostra i lati migliori dell’indumento. L’obi spesso ha un notevole disegno unico (tessuto o stampato), sul retro, che forma un grande nodo piatto, nello stile comune indicato come taiko (tamburo). Questo tamburo piatto, con una superficie di circa trenta centimetri, è volutamente incorniciato dal colore a contrasto del resto. Durante i primi o-zashiki, le maiko rimangono spesso incantate dall’armonia delle altre geisha sedute in perfetto stile giapponese. A un banchetto, solitamente, vengono infatti preparate tre file di tavoli bassi, che formano una u , parallelamente ai tre lati della stanza. Gli ospiti si siedono su dei cuscini individuali, bassi e quadrati, disposti nel lato esterno di questo ferro di cavallo. Nessuno si siede di fronte a un altro. Le maiko e le geiko spesso si spostano nello spazio centrale, libero, inginocchiandosi per qualche istante davanti all’uno o all’altro partecipante. Voltano quindi le spalle alla fila di tavoli sull’altro lato della stanza.
Del mio primo banchetto tradizionale, ogni maiko ricorda più di ogni altra cosa la bellezza della schiena della propria onesan e quasi per niente i volti dei vari invitati. A pensarci bene, forse, questa visione così d’effetto è tutt’altro che casuale!
La geisha è l’incarnazione della tradizione. Molte di queste artiste oggi tengono un blog o un sito e raccontano le loro esperienze, le loro paure sul web. Come si concilia tradizione e modernità in loro e nel loro mondo?
Nel passato del Giappone, le geisha sono sempre state le donne e le artiste più all’avanguardia, quelle che non solo dettavano moda ma che le inventavano, le mode.
Le geiko erano e sono la personificazione dell’Iki: dell’eleganza innata, della raffinatezza, di tutto ciò che è cool.
La loro immagine però si è formata nel passato feudale del Giappone e loro devono restarle fedeli, il più possibile, per rimanere geisha. Oggi non sono più innovatrici, quanto custodi della tradizione nipponica. La conservazione di una tradizione impareggiabile è il loro contributo sociale!
Conciliare il dovere del rispetto verso le regole della tradizione con le loro esigenze personali, di ragazze moderne, si può. Semplicemente essendo sempre se stesse. Sono artiste, ammirate e a volte venerate, ma allo stesso tempo sono ragazze e donne reali. Sono umane. Dietro la maschera bianca ci sono la carne, il sangue e l’anima. L’importante è non permettere a niente e a nessuno di rubarti l’anima. Alcune di loro iniziano a scrivere su un diario on line il giorno stesso in cui capiscono di voler diventare una geisha. Rappresenta una scelta appassionata ma complessa e lo scriverne sul blog le aiuta a ragionare meglio sul futuro. Cercano solo chiarezza e un po’ di conforto nella Scrittura. Ma un blog del genere chiaramente suscita, fin dal principio, un’incredibile curiosità e l’interesse di tantissime persone. Con il passare del tempo, probabilmente, decidono di continuare a raccontarsi, nel diario, per esortare tutti coloro che le leggono a visitare Kyoto e ad assistere alle incantevoli danze tradizionali delle maiko e delle geisha. Ovviamente, nei loro post, devono fare molta attenzione a non rivelare i segreti dei clienti. L’assoluta discrezione è la prima virtù che essi esigono da loro.
Se non rispettassero la loro privacy non potrebbero mai più lavorare come geisha, per il disonore. Nessuna di loro dunque può esporsi troppo, se non vuole danneggiare la sua okiya e perdere il favore dei patroni. A tal proposito spesso viene loro proibito di rivelare, sul blog, il nome professionale. Poiché solo una geisha in un determinato distretto utilizza un certo nome professionale, il rivelarlo, significherebbe esporre l’artista, la sua okiya e i relativi clienti a una pubblicità che nessuno di loro si auspica. Il karyukai è un mondo affascinante quanto fragile, come le ali delle farfalle che non si possono riparare se danneggiate… Tutto in esso si regge sulle fondamenta del mistero e del segreto tradizionale.
Le geisha offrono agli uomini piacere: secondo te, quando le incontrano, cosa li fa star bene?
Il fatto è che le geiko donano loro un sogno. In loro compagnia, si sentono diversi: migliori. Un o-zashiki, per gli uomini, è proprio questo: un sogno, un sogno che diviene realtà. Il cuore di un uomo è il cuore del Giappone e finché il cuore del Giappone batterà per una geisha, entrambi sopravvivranno
E che cosa fa star bene una maiko?
L’arte la rende felice e la fa sentire bene con se stessa. Un’apprendista geisha desidera diventare un’artista completa e mantenersi con i frutti del suo lavoro, nella danza e nella musica.
Ella persegue l’arte (gei) come vita: se per una geisha il gei è vita, allora è anche vero che il suo gei deve diventare arte. Levigare la propria esistenza in un’opera d’arte, per quanto possa sembrare un’ambizione elevata ai non giapponesi, è l’idea che sottende alla disciplina di una vera geiko. Nulla vuole con più convinzione: desidera divenire l’incarnazione vivente dell’Iki.
Il suo corpo è curato elegantemente in ogni dettaglio dell’abbigliamento e del trucco e la sua mente è altrettanto coltivata per raggiungere la perfezione. Quale rapporto hanno piacere fisico e intellettuale nell’attività di una geisha?
L’intrattenimento con le geisha, nelle o-chaya, non implica assolutamente un rapporto sessuale, come molti erroneamente credono, e loro non ritengono la conoscenza delle quarantotto posizioni un aspetto fondamentale del proprio repertorio professionale. Anche anticamente le professioniste del sesso erano solo le yujo, o donne di piacere.
Le geisha sono oggi e sono sempre state artiste.
Al contrario, durante la sua iniziazione al toko no higi, l’arte erotica , una giovane yujo veniva istruita su come appagare un uomo e anche su come farlo godere in fretta, fingendo un orgasmo convincente… Infatti ella doveva imparare a conservare le proprie energie per molti clienti, nella stessa notte! Oggi, al di fuori del lavoro, ciascuna maiko o geiko può decidere con chi passare la notte…
Sotto la maschera bianca si nasconde una donna in carne e ossa, quindi anche a una geisha può capitare, al di fuori dell’okiya, di avere un’avventura o di innamorarsi di un uomo. Che sia o meno un suo cliente! Ma sul luogo di lavoro il loro ruolo è quello di intrattenitrici artistiche: cantano, danzano, allietano gli altri con la cultura, l’umorismo e la sottile ironia. Nient’altro. Riguardo al Mizuage, inteso come pratica di mettere all’asta la verginità di una maiko, un tempo esisteva realmente ma oggi per fortuna non è più in uso. In passato, fino al 1958, però nessuna maiko poteva esimersi dal subire un tale rituale se voleva essere riconosciuta come una vera geisha.
Qual è la parte del suo corpo che una maiko preferisce?
Le labbra. Sono l’ultima parte che trucca, prima di uscire, ma certo non la meno importante.
Le dipinge con il rossetto tradizionale: il Kyo beni, il rosso di Kyoto. Miscela la polvere purpurea con l’acqua e aggiunge un’altra polvere per dare luminosità. Usando un sottile pennello disegna, con attenzione, solo il centro del labbro inferiore: non può ancora colorare il superiore poiché ha appena compiuto solo il primo anno di studi da maiko.
Quando ha terminato, la guarda, entusiasta, la cara onesan: le ripete che per gli uomini giapponesi le labbra sottili sono considerate molto attraenti e che la sua morbida mezzaluna li manderà in estasi.
Come maiko si hanno già dei clienti? Si partecipa a delle cerimonie?
Certo, la formazione prevede sia una parte teorica che una parte pratica. Le maiko accompagnano dunque la propria onesan a tutti i suoi appuntamenti (o almeno a tutti quelli nei quali è ritenuta opportuna la loro presenza). Le maiko in genere sono molto silenziose nei grandi banchetti ufficiali. Come apprendiste stanno ancora imparando il modo di comportarsi da geisha e la maggior parte di loro non ha ancora acquisito il bagaglio di esperienze necessario per sentirsi a proprio agio, soprattutto in presenza di alti funzionari governativi giapponesi o di statisti stranieri o di importanti uomini d’affari. Una maiko però non deve essere spiritosa: basta che rimanga seduta con aria modesta e l’aspetto di una bella bambola dipinta. Se si dimostra intelligente oltre che carina, tanto meglio, ma non ci si aspetta da lei che sappia condurre autonomamente una conversazione. Questo è di pertinenza delle geisha più anziane: esse ormai devono tingersi i capelli per ottenere il nero lucente che desiderano ma, grazie ai lunghi anni di esperienze acquisite, conoscono il modo migliore per distrarre l’interlocutore dai suoi pensieri con chiacchiere piacevoli ed innocue. Per questo motivo i banchetti in genere vengono organizzati in modo che siano presenti sia geisha, giovani e anziane, sia inesperte maiko: quelle più giovani, soprattutto le maiko con il loro aspetto tradizionale, creano l’atmosfera mentre quelle più esperte si dedicano a intrattenere gli ospiti. Una festa con solo maiko sarebbe inconcepibile.
Partecipano, in base alle disposizioni della loro okasan, anche alle manifestazioni religiose e culturali nelle quali viene coinvolta l’okiya di appartenenza. Hanno l’onore di ballare alle Kitano Odori: le Danze di Primavera. Si tratta di un evento molto importante per tutte: celebrano la magnificenza nella stagione della fioritura del ciliegio. La primavera inizia con le Miyako Odori (Miyako dances ) nel distretto di Gion, presso il Gion Kobu Kaburenjo Theater (1/4-30/4), e con le Kyo Odori nel Miyagawa-cho, al Miyagawa-cho Kaburenjo Theater (7/4-22/4), seguite dalle Kitano Odori nel Kamishichiken hanamachi (Il distretto di Sotori), presso il Kamishichiken Kaburenjo Theater (15/4-25/4), e dalle Kamogawa Odori in Ponto-cho, al Ponto-cho Kaburenjo Theater (1/5-24/5).
In Autunno, invece il quartiere di Gion Higashi celebra le sue Gion Odori, al Gion Kaikan (1/11-10/11).
Che rapporto si instaura fra una geisha e i suoi clienti?
Il primo pensiero di una geiko deve essere sempre e solo quello di onorare il cliente, però è anche vero che hanno le loro preferenze in materia. Come dicevo, è un dovere per le geisha essere le donne più Iki del Giappone. Iki potrebbe essere tradotto come cool , per intenderci. E anche per questo loro apprezzano maggiormente i clienti Iki. Alcuni dei loro patroni le trattano come semplici dispensatrici di un’atmosfera costosa che accentui l’immagine raffinata che loro vogliono creare, per se stessi e per i loro invitati. In privato, le geisha sono propense a definire gli uomini di questo genere insensibili…
Ma il cliente ideale è molto differente. Si presuppone che egli richieda la loro compagnia nei banchetti degli o-zashiki perché preferisce la loro compagnia a qualsiasi altro svago. Un patrono Iki deve anche intendersi delle arti professate dalle geiko ed essere spiritoso e affascinante. In un certo senso deve divertirle quanto loro divertono lui. E poi ci sono i clienti speciali che le geisha chiamano danna (marito).
Il danna in teoria è colui che si occupa di tutto ciò di cui una geiko ha bisogno, paga le sue spese, acquista i suoi costosissimi kimono, è il finanziatore dei suoi spettacoli, la sommerge, letteralmente, di regali e a volte, se è particolarmente generoso, le compra anche un’abitazione o addirittura una o-chaya tutta sua.
Un danna è ormai una cosa rara, poiché sono decisamente pochi gli uomini che possono permettersi di mantenere due donne (la moglie ufficiale e la geisha favorita). Inoltre la maggior parte di loro preferisce comunque continuare a lavorare, anche dopo aver trovato un mecenate. Un rapporto di tal genere non implica necessariamente un coinvolgimento sentimentale o sessuale, ma a volte può accadere che ci sia anche questo aspetto tra il danna e la geiko.
L’importante però è non innamorarsi, mai. Una geisha che ama il suo patrono deve affrontare, quotidianamente, il problema psicologico di vivere come la seconda donna nella vita di quell’uomo. Se una geiko è davvero infatuata del suo protettore, alla fine il fatto che lui sia sposato con un’altra la consumerà! Secondo le sagge onesan, questo è il maggior rischio nella loro professione: se non sono prudenti, possono ritrovarsi con il cuore spezzato. E’ molto meglio seguire i buoni consigli delle okasan: non sprecare la vita a commiserarsi per il crudele destino di non poter avere il proprio danna tutto per sé, ma lavorare con passione, frequentare le lezioni e intessere profonde amicizie, nel karyukai, che le accompagneranno per l’intera carriera ed esistenza.
I kimono sono vere opere d’arte. Quale significato hanno?
Il kimono che le geiko indossano racconta tutto di loro: chi sono, in quale okiya vivono, che livello hanno raggiunto nelle arti e quale stagione, dell’esistenza e dell’anno, stanno attraversando. Il primo giorno di giugno in tutte le okiya si svolge lo stesso rito: il cambio del tipo di kimono che le geiko indossano. Le sottovesti vengono aperte sui tatami e la okasan taglia i fili che fissano il colletto bianco, in grosgrain di seta, alla sottoveste. L’ampio colletto è l’unica parte visibile della sottoveste, ma è molto importante. Le geisha possono anche tamponare spesso le inevitabili macchie di trucco che lo sporcano ma, dopo un po’, è necessario staccarlo e cucirne uno nuovo. Hanno la sensazione di sbarazzarsi degli ultimi resti dell’inverno quando il primo di giugno i vecchi colletti, sporchi o puliti che siano, vengono tolti e il ro a righe a trama larga ne riceve uno nuovo, in pura seta.
Mono significa cosa e il prefisso ki deriva da kiru, indossare : kimono quindi significa semplicemente indumento . Ma non tutte le cose da indossare sono dei kimono!
Oggi la principale distinzione è tra yofuku, tenuta occidentale , e wafuku, tenuta indigena (kimono). Ormai la maggior parte delle donne giapponesi indossa quasi sempre abiti all’ultima moda. Alcune non possiedono neanche un kimono e molte hanno dimenticato come indossare quello che conservano nell’armadio: un modello nero con stampato sopra lo stemma di famiglia, il pezzo forte del loro corredo di nozze. In effetti sono rarissime le occasioni sociali alle quali non si può partecipare se non se ne possiede uno.
Le stagioni influiscono decisamente sul tipo di kimono. Al pari di una poesia haiku, un kimono deve esibire un motivo stagionale riconoscibile. La differenza tra le quattro stagioni si esprime chiaramente anche nell’esistenza di tre tipi distinti di questo indumento, oltre che nei colori e nel suo motivo decorativo. Da settembre ad aprile si indossano i kimono foderati detti awase: in pesante crespo di seta con una fodera più leggera di crespo o mussola di seta. In passato, per la fodera, era di moda il rosso, ma ora sono più indicati il bianco pastello, il crema o il bokashi (più colori sfumati). Gli awase dunque si indossano otto mesi l’anno, quelli hitoe, sfoderati, solo a maggio e, volendo, a giugno, quelli ro, ancora più leggeri, da giugno ad agosto. Un awase pregiato è in assoluto il tipo più costoso che esista!
Le maiko e le geiko sono destinate a cambiare il peso degli indumenti in base al calendario e non alle effettive condizioni climatiche. Il loro guardaroba quindi fa eco alle stagioni più di quello di una qualunque altra giapponese. Se per caso a maggio dovesse fare caldo, non possono indossare il kimono estivo, con la sua trama larga, disegnata appositamente per essere più fresca. Il caldo fisico che devono sopportare non è importante quanto il costume culturale che sancisce l’inizio dell’estate a giugno e non a maggio. La lunga veste formale nera (kuro mon-tsuki) del Nuovo Anno a gennaio viene sostituita dallo stesso tipo di veste ma a colori (iro mon-tsuki). A febbraio e a marzo si indossano due strati di kimono (nimae gasane). In aprile le occasioni ufficiali richiedono una veste foderata con l’orlo imbottito e a maggio una senza imbottitura. Giugno regala gli hitoe sfoderati, luglio il leggero crespo di seta e agosto la seta a righe a trama larga. Poi da settembre si ricomincia con l’awase…
Sotori è innamorata?
Prima di entrare nell’okiya, frequentava un ragazzo del suo quartiere: Takagi.
Non conosce ancora il significato della parola Amore, ma ha sperimentato il sesso con lui. Ha fatto l’amore (e non ancora all’Amore) per ben due volte, con Takagi, in quel pomeriggio assurdo in cui gli ha detto addio. Il giorno in cui ha ricevuto la lettera con la quale la okasan la accettava ufficialmente nella okiya. Ha dunque già perso la preziosaverginità e non avrebbe potuto rendere nulla alla sua okami (geisha mother) se l’antico rituale del Mizuage fosse ancora in vigore. A meno che non si fosse prestata al meschino espediente di alcune geisha del passato che indugiavano nel Mizuage numerose volte. Tante quanti erano gli ingenti guadagni che potevano ricavarne…
E la famiglia? Una geisha non può sposarsi e avere figli, vero? Dopo un po’ di anni ne sente il desiderio?
In teoria possono avere dei figli, ma non sposarsi. Almeno finché desiderano lavorare come geisha. Molte tra loro ad un certo punto si innamorano e abbandonano la professione, per coniugarsi con l’amato.
Altre invece non la lasciano mai. Il 6 agosto 2007 Sotori ha compiuto 18 anni, è ancora troppo giovane per pensare al matrimonio. L’unico suo desiderio, in questo momento, è completare gli studi da maiko. Non sarà semplice riuscire ad arrivare fino in fondo, quindi è concentrata solo su questo.
Come viene vissuto il sesso in Giappone?
A questo proposito dobbiamo parlare meglio del Mizuage.
La madre dell’okami di Sotori è stata costretta a sottoporsi a questo rito cerimoniale per poter diventare una vera geisha. Il responsabile della cerimonia si comportava con la maiko come un fuco con l’ape regina: dopo aver espletato la sua funzione, non aveva più alcun legame con la fanciulla. Il Mizuage un tempo era un procedimento molto elaborato che si protraeva anche per sette giorni, quando il patrono vincitore desiderava aprirsi il varco nel corpo della maiko con le proprie dita, a poco a poco, molto lentamente, finché ella non era finalmente pronta per la penetrazione vera e propria. La okasan, oppure una delle geisha più esperte, preparava una camera adatta al rito e in essa collocava tre uova sul copriletto accanto al cuscino. Infine si ritirava in una stanza adiacente e da lì, ogni tanto, tossiva o si muoveva per rassicurare la maiko con la sua vigile presenza. L’uomo attendeva nella camera l’ingresso dell’apprendista e, al suo arrivo, la invitava a sdraiarsi: prima rompeva le uova e ingogliava i tuorli, poi strofinava gli albumi sulle cosce della fanciulla. E nel farlo pronunciava parole come: questo è il Mizuage, buonanotte mia cara … Poi spegneva la luce. La sera seguente la camera veniva preparata allo stesso modo e l’uomo si comportava nella medesima maniera: ogni volta però egli infilava le dita cosparse dello scivoloso albume un po’ più profondamente dentro di lei. Al termine della settimana rituale, la maiko si era abituata a questo procedimento ed era molto più rilassata. L’uomo a sua volta, rinvigorito dai sette tuorli d’uovo, poteva portare a termine il proprio compito senza ostacoli. Quindi egli spogliava la fanciulla della sua verginità, durante la notte ritenuta favorevole dall’indovino di fiducia. Solo dopo l’evento la maiko poteva cambiare il collare, dal rosso al bianco, e la pettinatura, dallo stile Wareshinobu all’Ofuku, divenendo una vera geisha e facendo il suo ingresso nell’età adulta.
Un tempo nessuna maiko poteva esimersene, se voleva che la sospirata metamorfosi in una geiko avesse luogo, per essere universalmente riconosciuta come tale nel karyukai. La verginità della giovane maiko veniva praticamente messa all’asta tra gli aspiranti acquirenti: ad ognuno dei pretendenti l’apprendista offriva un simbolico ekubo, un dolce di riso candido come la neve e con un evocativo cuore rosso al centro. In genere era la okasan a occuparsi di portare avanti l’asta, di sancire il vincitore e organizzare la relativa cerimonia: l’uomo che avrebbe avuto tale privilegio aveva una grande responsabilità. Non doveva quindi essere troppo giovane, un ragazzo sarebbe stato troppo rude! Al contrario doveva essere un gentiluomo molto anziano e molto ricco. La cifra pagata dal fortunato andava comunque all’okiya per sanare una parte del debito accumulato dalla fanciulla. Indubbiamente, un tempo, il sesso era semplice nel mondo delle geisha più anziane…
Una maiko era vergine e la sua iniziazione sessuale faceva parte della routine per diventare una vera geisha. Le ragazze giapponesi abitualmente mettono da parte i kimono dalle ampie maniche quando si sposano (cioè diventano adulte), le maiko lo fanno quando diventano geisha!
Un tempo, in entrambi i casi, il cambio nel tipo di kimono presupponeva l’acquisizione di una esperienza sessuale. Una geisha già in servizio e ancora vergine sarebbe stata inconcepibile quanto una ragazza già moglie e ancora illibata . Secondo molte okasan, ora la libertà di scelta della quale si gode ha confuso queste categorie ben definite. Una maiko di una nota okiya, una notte, è uscita di nascosto per incontrare il suo ragazzo e consumare con lui la sua prima notte… Un’altra geisha, molto famosa e apprezzata nel distretto di Kamishichiken, invece è ancora vergine… Tutto questo crea caos, secondo le okami più tradizionaliste, comunque io sono sicura che le giovani allieve siano felici di vivere come maiko oggi. Tutte le maiko sono liete che questo rito di passaggio non sia più in uso, perché altrimenti, tutte dovrebbero subirlo ancora. Nelle okiya quando si nomina (raramente) il Mizuage si intuisce sempre un lieve imbarazzo in alcune delle geiko più anziane, mentre le giovani ascoltano attentamente, ovviamente incuriosite.
Adesso le geisha (e le donne giapponesi in generale) hanno un maggiore controllo sulla propria sessualità rispetto al passato. Persino le geiko più anziane approvano pienamente che le loro figlie non debbano sottoporsi al Mizuage, ma questo implicitamente significa che le loro esperienze invece di essere ritenute un valido esempio per le più giovani verranno da loro scartate come feudali . Feudale è un termine usato, in Giappone, non solo con un significato storico/politico ma anche in riferimento a qualsiasi usanza considerata come fuori moda , obsoleta e non illuminata.
Dunque le geisha anziane parlano più liberamente di sesso quando le giovani non sono presenti… Temono di essere mal giudicate da parte loro, ma non è così!
Certamente loro non le giudichiamo per ciò che hanno vissuto, semplicemente sono liete di essere libere di scegliere con chi passare o non passare la prima notte e tutte le successive.
Ho letto che fare la geisha è un mestiere di lusso. Quanto guadagna una geisha? (ci puoi fare un paragone rispetto ad uno stipendio medio). Gli studi di una maiko ora sono molto costosi?
Sì, la formazione di una maiko è molto costosa e tutte le spese sono sostenute dalla okasan della okiya di appartenenza. Quando la maiko diviene una vera geiko e inizia a lavorare come tale, deve ripagare la sua geisha mother di tutte le suddette spese.
Una geisha apprezzata e stimata guadagna parecchio, anche se solo una parte della tariffa va a lei (il resto va agli intermediari della teahouse in cui lavora e della geisha house in cui vive). L’onorario varia secondo la fama e la bravura (la bellezza è un elemento secondario). Una geisha, per un’intera serata, riceve anche duemila o tremila euro. Non è poco ma le spese che deve sostenere sono ingenti. Comprare un kimono è molto costoso e loro devono indossare un tipo di kimono diverso ogni mese. Ciò significa che nell’armadio ce ne devono essere almeno tre, per ogni mese dell’anno: uno lo indossano, uno sarà in tintoria e l’altro è per le emergenze. Sono quindi trentasei kimono all’anno, e ogni kimono costa minimo dai diecimila ai quindicimila euro. E’ per questo che, generalmente, le geisha desiderano un mecenate. In Giappone esiste un registro delle geisha dove sono segnate quelle di città, che sono le uniche vere geisha. Il totale di queste è circa duemila. In tutto si arriva a cinquemila, contando anche le tremila onsen geisha (le apprendiste ). A Kyoto le geiko sono circa duecentotrenta, di cui cento sono maiko. Sul proprio sito l’associazione Ookini Zaidan fornisce la descrizione del complesso percorso che aspetta un’aspirante geisha. Le maiko vivono e lavorano in uno dei cinque kagai, o hanamachi, che erano un tempo i quartieri del piacere a Kyoto. I dati più vecchi attualmente consultabili parlano di 76 maiko a Kyoto nel 1965. A partire dal 1975 ce ne furono solo 28, e il dato si stabilizza di nuovo dopo il 1985, oscillando da 50 a 80 maiko. Fino al 1955 sembra che a Kyoto ci fossero più di 100 maiko, precisa Ito Osamu, un funzionario della Ookini Zaidan. Secondo l’associazione culturale l’interesse dei media per il mondo delle maiko è l’unico responsabile del recente aumento di aspiranti geisha.
Keiko, che ha 16 anni ed è di Osaka, è diventata la centesima maiko il 23 marzo 2008 quando si è svolta la cerimonia per il suo misedashi, con la quale è entrata ufficialmente in una esclusiva o-chaya ed è stata introdotta nel mondo delle geiko. “Sono molto felice”, ha detto Keiko. “Sognavo di diventare una maiko fin da quando ne vidi, per caso, una in televisione”. L’adolescente si è diplomata lo scorso anno alle scuole superiori. Ayano, 17 anni e nata a Tokyo, ha celebrato il suo misedashi il 6 marzo 2008, trovando informazioni su come diventare maiko in Internet dopo aver visto un famoso reality. Tokyo ha più o meno lo stesso numero di geisha rispetto a Kyoto. Vanishing world? No, sicuramente non scompariranno mai del tutto, ma la vera incognita sono i clienti perché molti dei più fedeli tra loro ora sono anziani. E anche essere un cliente è un’abilità e un mestiere.
Dunque nel 2008 c’è stato un boom di maiko grazie a Internet e alla televisione?
Navigare in Internet e guardare la televisione possono essere attività alquanto banali oppure esperienze che ti cambiano la vita, dipende da chi le sta facendo! L’Asahi Shimbun conferma che per un crescente numero di ragazze giapponesi Internet e TV sono stati determinanti nell’incoraggiarle a diventare maiko.
Per la prima volta in quarant’anni, nel 2008 il numero delle maiko, a Kyoto, è arrivato a quota cento, grazie al crescente aumento d’interesse verso la cultura tradizionale delle geisha di Kyoto. Le apprendiste geiko sono giunte qui da ogni parte del paese, dopo aver visto uno short drama di 15 minuti, che è in onda ogni mattina e racconta la vita di una maiko, e grazie anche ad alcuni eventi organizzati per promuovere il turismo nell’Antica Capitale.
Molte altre ragazze ne hanno voluto sapere di più dopo aver visitato il sito web della Kyoto Traditional Musical Art Foundation (Ookini Zaidan, ?????? ), il cui scopo è quello di tramandare alle nuove generazioni la musica e la danza tradizionali.
Il sito della Ookini Zaidan riporta dieci condizioni che un’aspirante maiko deve tenere sempre in mente e che sono requisiti necessari per intraprendere questo mestiere:
1. Maiko is an apprentice of professional female entertainer
It is not an ordinary job. Maiko is an apprentice who wish to be full hedge entertainer.
2. The age must be between 15 and 17
It is too late to start the training period when you finish high school (18 years old). The best timing is 15 years old.
3. The height should be shorter than 160 cm
A maiko should not be too tall. When you wear okobo (high wooden shoes), it will add another 10 cm on your height.
4. The weight must be over 43 kg
Because the maiko costume is really heavy, you have to be over 43 kg .
5. Parents’ consent
Because you are under 20, you need the permission from your parents to be a maiko.
6. Fondness to traditional Japanese entertainment
You don’t have to have an experience, but it is important that you have a sense of sound.
7. Fondness to Japanese life style
Everything is Japanese style: kimono, tea ceremony, flowers arrangement, ozashiki (Japanese room) manner and you have to use high wooden pillow when you go to bed. Therefore you must love Japanese style living.
8. Overwhelming patience
While you are in shikomi period (pre-training before maiko), everything must be learned: manners, washing, cleaning, shopping, other trivial things in the life and what is the most important is to learn how to speak Kyoto dialect.
9. No monthly tuition fee required
You don’t have to pay for anything. Everything including living expense, lesson fee, etc. are responsible for okiya.
10. Training period
Including shikomi (pre-training before maiko) and disciple period, you have to expect to spend 4-5 years as a maiko.
These are 10 necessary conditions to be a maiko, and of course this is not everything. Another important point is if you can make a good relationship with your elder maiko and geiko. The okasan (the manager) will strictly watch you while you are in training…
Il motto della Ookini Zaidan non lascia dubbi:
O – Otagai ni (each other)
O – Omoiyari (to respect others)
Ki – Kikubari shite (to be sensitive to others’ feelings)
Ni – Nikoya Ni (with smile)
…
Una maiko è, in genere, molto giovane: cosa spera per il suo futuro?
Amore, solo questo desidera. E ora sa dove trovarlo. Sa perfettamente chi vuole essere: una geisha.
Sensuale e perfetta, assoluta padrona dell’arte d’amare se stessa. Ambisce a raggiungere la perfezione dell’Iki, null’altro vuole con eguale intensità. Una geisha custodisce la propria arte dentro se stessa e, poiché il suo corpo rappresenta tale arte, la sua vita è preservata. E’ questo il potere dell’Iki: l’eterna salvezza per l’anima di ognuna di loro.