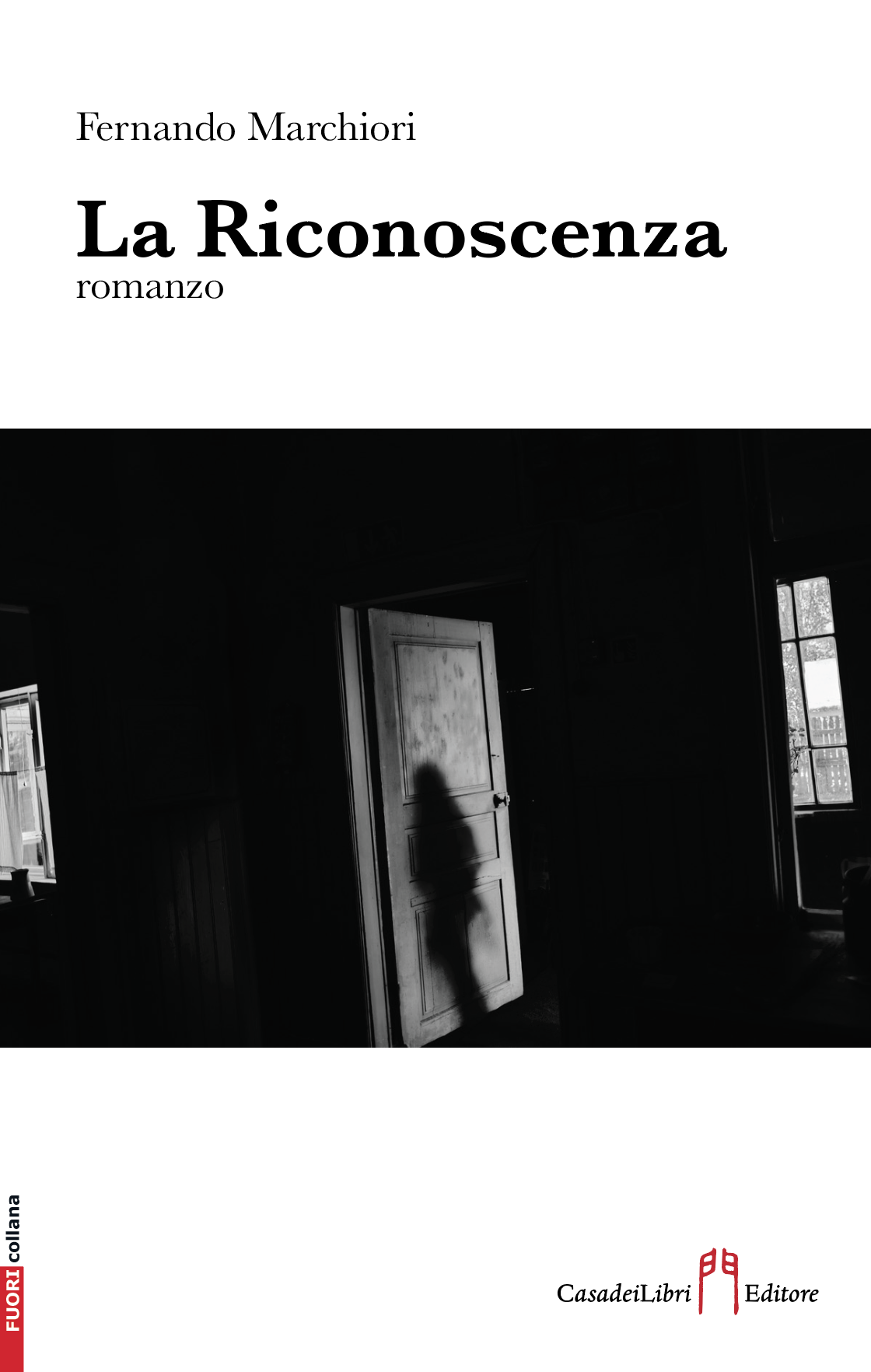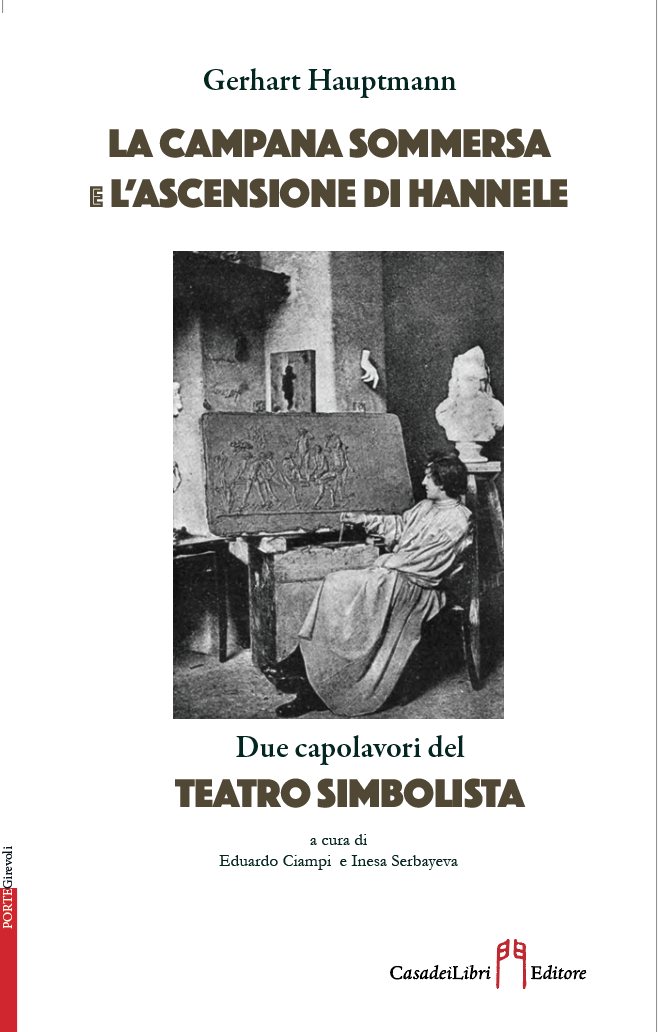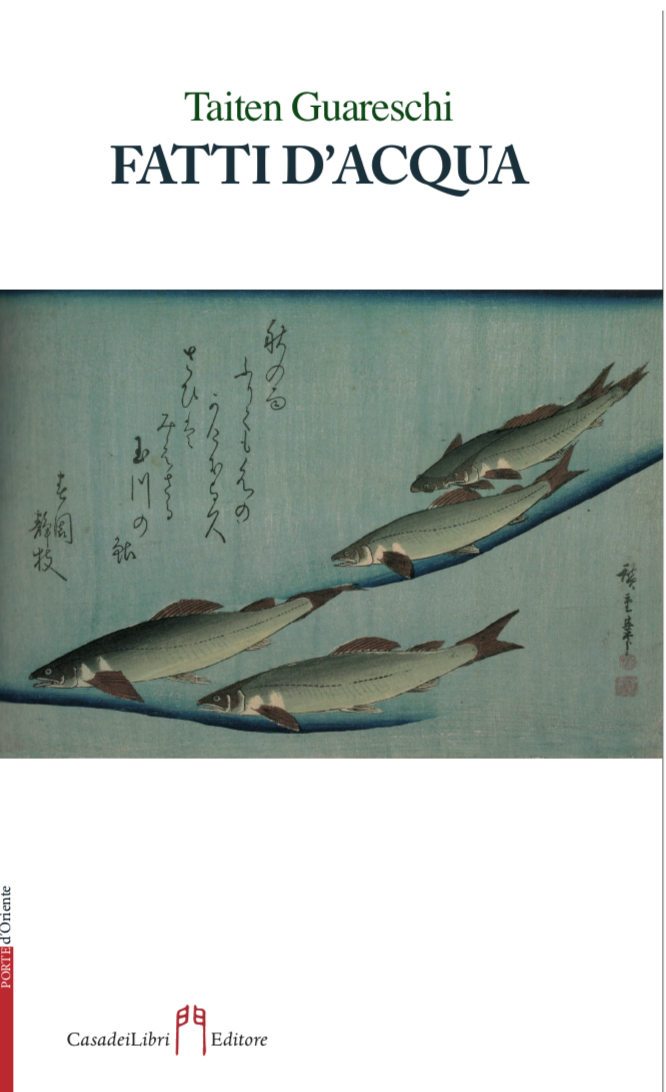John Florio, un elisabettiano d’Italia: saggio di Frances Yates
di Luca Scarlini
Prima di dedicarsi ai saggi della maturità sui Rosacroce e a quelli molto noti su Giordano Bruno fra gli altri, Frances Yates aveva licenziato agli esordi della sua attività di studiosa eclettica una monografia su John Florio, che esce ora in una edizione curata da Giorgio Ghiberti per Casadeilibri (pp. 486, € 30,00), editore che nel 2014 ha proposto una biografia della stessa Yates, a firma di Marjorie R. Jones. I primi interessi della storica erano concentrati sulla cultura francese del Rinascimento e i suoi effetti in Gran Bretagna, da qui l’interesse per lo scrittore di origine italiana, che aveva tradotto magistralmente l’opera di Montaigne. Florio era figlio di valdesi, originari della Toscana (forse Siena, o Lucca), fuggiti a Londra dalla Valtellina per le persecuzioni religiose, dopo che per un editto della corte avevano dovuto abbandonare il paese, vagando tra Strasburgo e la Svizzera. Al tempo in cui Yates scriveva molte erano le biografie lacunose degli autori rinascimentali in Inghilterra: il primo interesse del libro è ricostruire, con grande precisione, l’ambiente dei transfughi religiosi, che avevano trovato ospitalità oltre la Manica. Il padre di John, Michelangelo, era predicatore nella chiesa degli italiani, che gli assicurava un reddito, ma, agitato da diverse tensioni, si scontrò con la comunità, per questioni teologiche, nel momento in cui si affermava il radicalissimo pensiero di Bernardino Ochino, che divulgava la teoria della predestinazione e predicava la poligamia trovandone il fondamento nella Bibbia. Florio abbandonò quindi il mondo religioso e divenne docente di lingua italiana, materia che appassionava le élites britanniche, inclusa la regina Elisabetta, con cui forse ebbe relazioni didattiche. A venticinque anni, di ritorno a Londra, pubblicò nel 1578 il libro d’esordio, I primi frutti, che trae ispirazione dalle Hore di ricreatione di Lodovico Guicciardini e dal Libro aureo di Antonio De Guevara, in cui riscriveva Marco Aurelio.
Negli anni tra il 1583 il 1585, lavorando presso l’ambasciata francese, Florio conobbe Giordano Bruno (da lui definito «il mio vecchio compagno nolano»), con cui ebbe un intenso scambio intellettuale. Compare ne La cena delle ceneri, come latore dell’invito di Fulke Greville per un trattenimento-dibattito a cui partecipano anche un cavaliere e due teologi luterani di Oxford. A questo incontro determinante, l’autrice dedica il quinto capitolo del libro. Negli anni seguenti la ricerca intellettuale porta Florio ad altri due risultati importanti: nel 1591 escono i Secondi frutti, una collezione di parole e di esempi, con seimila proverbi italiani di cui si ritroverà traccia nelle opere di Shakespeare, ciò da cui nasce la celebre teoria, più volte affermata e smentita, per cui il Bardo sarebbe da identificarsi con lo scrittore italiano. Nel 1598 comparve poi A World of Words, primo dizionario di italiano, che permise agli intellettuali inglesi di potere frequentare con più agio le pagine di Boccaccio e Dante. Opera giovanile di Yates, questa biografia è notevole nella ricerca dei reperti culturali di un’epoca contrastata, in cui le ideologie e le religioni si scontravano continuamente, esponendo gli intellettuali a possibili ascese (Florio fu protetto dal principe Henry e ebbe grandi successi sotto il potere della regina Anne) e a repentini disastri (lo scrittore perse tutto dopo la morte del suo protettore). Il libro è del 1934: l’autrice scriveva in un passaggio storico imbevuto di retorica imperiale, che gli scrittori del Bloomsbury Group avevano da poco passato al filo di spada dell’ironia più selvaggia. Basti l’esempio di Lytton Strachey nel crudele La regina Vittoria (1928), senza scordare gli affondi leggiadri del coevo Orlando di Virginia Woolf. Il lavoro di Yates proponeva documenti nuovi, frutto di lunghe ricerche, e così come nel celebre studio dedicato a Bruno, John Florio è anche la ricostruzione di un’epoca, in un testo che tiene insieme il disegno complessivo e i dettagli di un’esistenza complessa, guidata dalla ricerca intellettuale del confronto tra culture e paesi, fino all’ultima impresa: la collaborazione all’edizione completa del Decameron boccaccesco, la prima in lingua inglese, destinata, come la versione di Montaigne, a notevole fortuna.

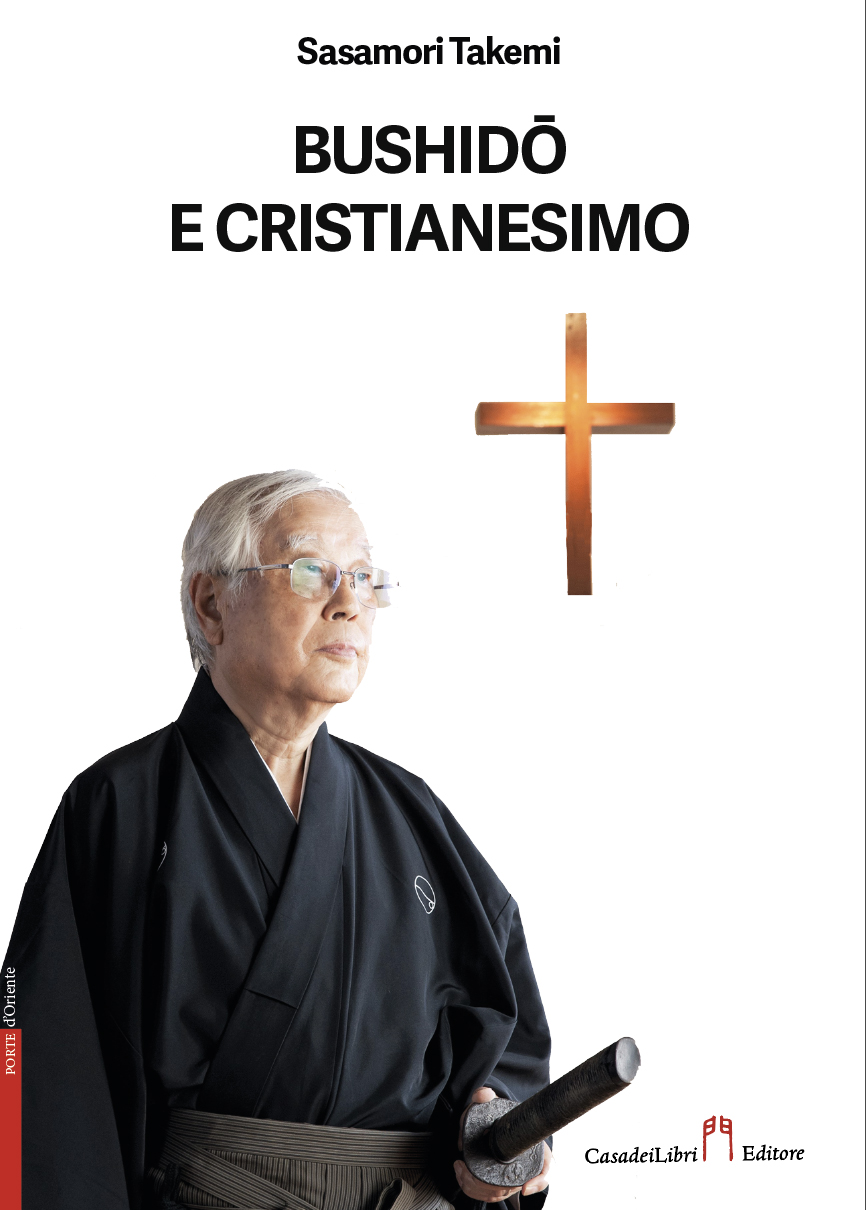 ISBN
ISBN